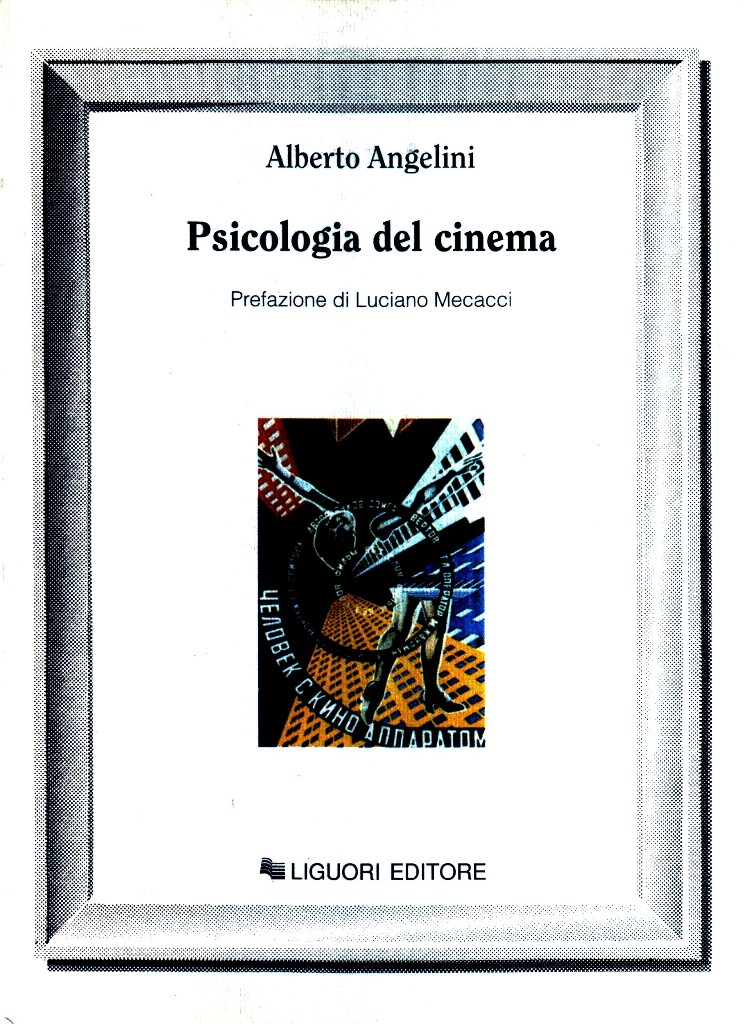
Psicodinamica dello spettatore cinematografico
Alberto Angelini
Eidos cinema e psiche, numero zero, 2004
Nel buio ovattato della sala cinematografica, l’individuo sospende temporaneamente il corso della vita normale. Accade qualcosa che è stato paragonato alla profondità del sogno e alla passività dell’ipnosi. Si allenta, parzialmente, la sorveglianza che esercitiamo su noi stessi. Gli impulsi e le fantasie insoddisfatte nella veglia, ma a cui non riusciamo a rinunciare, manifestano la loro esistenza.
Molteplici elementi indicano che il cinema dialoga con l’inconscio ed i suoi affetti. Lo spettatore partecipa emotivamente alla vicenda filmica tramite due meccanismi psicodinamici fondamentali: l’identificazione e la proiezione. Col termine identificazione si designa un processo psicologico con cui un soggetto assimila un aspetto, una proprietà, un attributo di un’altra persona e si trasforma, parzialmente o totalmente, sul modello di quest’ultima.
Alla costituzione e differenziazione della personalità contribuisce una lunga serie di identificazioni. Le identificazioni protratte conducono addirittura all’adozione di comportamenti, mentali, motori ed emotivi altrui. D’altra parte, la personalità individuale reagisce continuamente alla forza del meccanismo identificativo che, se non incontrasse tale reazione, finirebbe per annullare completamente le caratteristiche del soggetto, come avviene nelle situazioni patologiche.
Durante lo spettacolo cinematografico i fenomeni di identificazione sono particolarmente intensi. Ciò è anche dovuto alle caratteristiche oniroidi della situazione e alla consapevolezza, da parte dello spettatore, dei limiti di tempo propri della visione cinematografica. Ciò rassicura chi vede un film e gli consente di abbandonarsi con tranquillità, ai processi psichici che il cinema innesca e che ne hanno sostanzialmente determinato il successo storico come strumento espressivo. Inoltre, anche il film tende a polarizzare l’identificazione dello spettatore su un personaggio principale che coincide, generalmente, con il protagonista, i meccanismi identificativi agiscono, più o meno inconsciamente, anche rispetto agli altri personaggi detta vicenda cinematografica. Il personaggio nei confronti del quale l’autore del film favorisce l’identificazione è, in genere un individuo che pensa ed agisce come, secondo lo spettatore, sarebbe adeguato comportarsi nelle circostanze illustrate cinematograficamente. Spesso, i personaggi secondari consentono identificazioni laterali ed inconsce, colorate di sensazioni che, nella vita quotidiana, non sono permesse.
Il cinema consente, quindi, la soddisfazione di impulsi che la realtà non ammette. Ciò del resto, è proprio anche del romanzo e del teatro. Tipica del cinema è, tuttavia, l’alta intensità che si accompagna a questo processo. Ciò é dovuto alla “caratteristica di realtà” propria del mezzo cinematografico. IL termine “proiezione” indica, in senso molto ampio, l’operazione con cui un fatto psicologico è spostato dall’interno all’esterno, dal soggetto all’oggetto. Sul piano strettamente psicoanalitico, per proiezione si intende quel processo con cui l’individuo espelle da sé e localizza nell’altro, persona o cosa, della qualità, dei desideri e dei sentimenti che egli non riconosce o rifiuta. E una difesa che ha origini arcaiche e che agisce, particolarmente, nella paranoia. Non manca, però, di manifestarsi in forme di pensiero “normali”, come la superstizione. Sebbene in maniera subordinata, anche il meccanismo della proiezione agisce nella situazione cinematografica. La struttura, generalmente rigida ed articolata, del linguaggio filmico consente un limitato esercizio della proiezione. Tuttavia essa si manifesta, palesemente, ogni volta che lo spettatore tende ad attribuire ai personaggi del film sentimenti ed intenzioni che sono, più o meno consapevolmente, suoi. Com’è noto, diversi test psicologici si basano sul fenomeno proiettivo, allo scopo di mettere in evidenza elementi nascosti della personalità.





